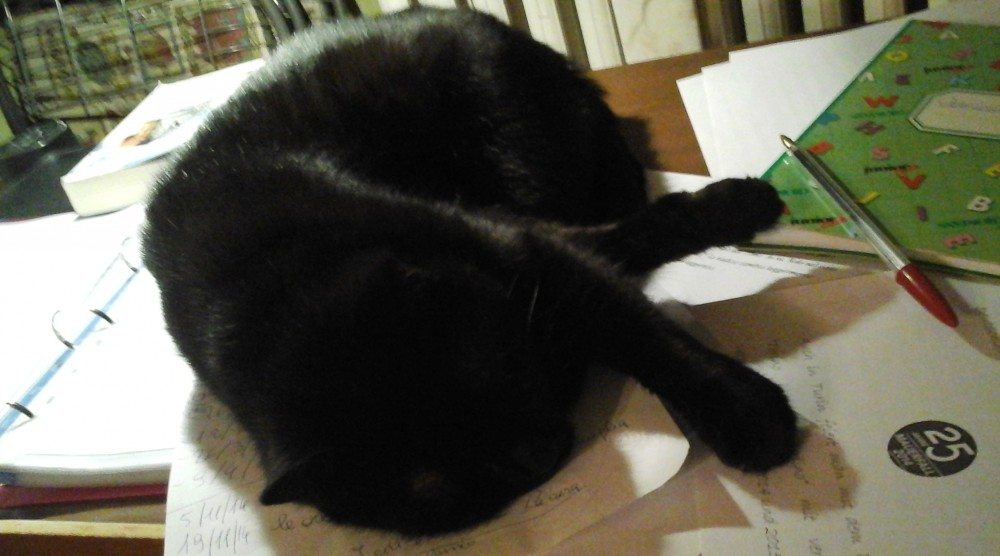di Silvia Riccio
E’ incredibile come a volte basti un niente per riportare a galla un mondo di ricordi e di emozioni direttamente dal mondo della tua infanzia spesso popolato da incubi. Tempo fa, sfogliando un libro per bambini, mi sono imbattuta in una particolare illustrazione.
Rappresentava una bimba sprofondata nel suo letto. Aveva gli occhi sbarrati e le manine che tiravano la coperta sul viso, nel vano tentativo di nascondere alla vista ciò che la circondava minacciosamente.
Da enormi ragnatele appese al soffitto dondolavano ragni dalle lunghe zampe mentre un pipistrello nero come una notte senza stelle, svolazzava sopra la sua testolina dalla lunga treccia rossa. Si vedevano anche dei topi dagli occhietti vividi e cattivi che si avvicinavano al suo letto agitando i codini che frustavano l’aria mentre altri orridi animaletti strisciavano sul pavimento! C’era veramente di che inorridire.
Un vero incubo illustrato in modo così realistico, che pareva di udire il respiro affannoso ed angosciato della piccola accucciata in quel letto di paura e solitudine. Ricordo che chiusi di scatto il libro. Non fui però abbastanza veloce da impedire la fuga di quelle immagini che sgusciarono fuori dalle pagine a risvegliare i miei ricordi assopiti da una vita nella parte più segreta del mio cuore.
Fu un attimo e mi ritrovai indietro di oltre sessanta anni come per effetto di una magia. Tutto mi ritornò alla mente…
A quei tempi abitavamo a Cagliari, in via Logudoro, in una casa di ringhiera, dove mia madre mi diede alla luce nella sua camera da letto, alla sinistra di un corridoio lungo e senza finestre. Fu proprio lì che nacque la più grande delle mie paure: quella del buio!
Ancora adesso lo temo perché mi fa pensare al nulla della morte, ad un buco nero senza confini, vasto quanto l’eternità stessa, che tutto ingoia…tutto quello che di prezioso esiste. E’ proprio il colore della mia paura che mi riporta alla mente Don Carletto, il Marchese Amat di Sanfilippo…
Mia madre aveva una cugina carissima Mercedes, che lavorava come governante nella casa dei nobili più nobili di Cagliari, la casa dei Marchesi Amat di Sanfilippo per l’appunto, imparentati alla lontana con Casa Savoia.
Una volta al mese andavamo a farle visita e la cosa mi dava allegria ed angoscia allo stesso tempo. La passeggiata per raggiungere la casa di Don Carletto era lunga e piacevole e ci si arrivava costeggiando la scalinata del Bastione di San Remy dove c’erano le giostre ed il carretto bianco e blu del gelataio.
Questa era la tappa dell’allegria, del sole e del cielo azzurro, del marmo bianco della scalinata, del mare turchese che vedevo attraverso il verde delle palme ed il giallo degli alberi di mimosa ed era anche il momento del cono gelato che mia madre mi comprava.
Il quartiere Castello, dove c’era e tuttora c’è la casa di Don Carletto, si raggiungeva attraverso vie grandi e piccole, case colorate, piazze dislocate qua e là, tetti e panni stesi, salite e discese. Ancora oggi vi si accede dalle porte medievali attraverso aperture nelle mura che circondano la città vecchia. Ci addentravamo in un mondo fatto di case eleganti dove da sempre abitavano i ricchi e gli uomini di potere della città.
La sfarzosa residenza degli Amat di Sanfilippo si trovava di fronte alla facciata del Duomo e sull’elegante portone che conduceva ad un bellissimo giardino interno, spiccava lo stemma araldico della famiglia. Quando io e mia madre arrivavamo, zia Mercedes ci aspettava sempre sulla soglia con le mani intrecciate sul ventre. Da quel momento il serpentello dell’in-quietudine mi si attorcigliava attorno al cuore e lo strizzava come un panno bagnato. Sapevo che da lì in poi i colori smaglianti della strada, della vita che pulsava attorno alla grande casa ed il profondo azzurro del cielo, sarebbero rimasti all’uscio come ospiti indesiderati. Oltre la soglia iniziava il mondo della penombra.
Mercedes, che io chiamavo zia, aveva lo sguardo arcigno di certe zitelle di una volta, quelle che sacrificavano l’intera esistenza per il bene della famiglia ignorando il proprio. Era buona e generosa nel dividere il suo relativo benessere con il fratello Antonio, proprietario di uno sparuto gregge e padre di tre figlioli.
Come si usava allora, era vestita di nero, calze comprese, anche durante le estati più cocenti e d’inverno si avvolgeva in uno scialle di lana scuro come la pece.
Entrando nella grande casa, si poteva notare che tutte le imposte dei finestroni e dei bellissimi balconi in ferro battuto, colmi di gerani e gelsomini profumatissimi, erano chiuse ed anche i tendaggi di pesante damasco erano tirati a coprire i vetri. Il sole con i suoi raggi più audaci, non riusciva a trovare la strada per trafiggere l’oscurità dell’interno e si fermava sconfitto dall’arcigna Mercedes, che sosteneva la luce avrebbe rovinato i mobili ed i preziosi tessuti degli arredi.
In quella casa chi comandava era lei e tutti filavano come dei soldatini. Persino il vecchio Marchese, che la zia chiamava con malcelato affetto Don Carletto, non discuteva mai gli ordini che lei impartiva.
Una volta entrati, a poco a poco, gli occhi si abituavano al quasi buio ma il mio cuore diventava sempre più stretto. Mentre la zia ci guidava attraverso la grande casa, io stavo aggrappata alla mano di mia madre con gli occhi chiusi immaginando che il buio attorno fosse popolato da lupi mannari e streghe cattivissime.
Non vedevo l’ora di entrare nella cucina, l’unico locale meno buio degli altri e consolarmi con i dolcetti di mandorle o quelli di ricotta, limone e zafferano che la zia mi preparava sempre, sapendo che erano i miei preferiti. Seduta al tavolo di marmo, che ai miei occhi di bambina sembrava lungo quanto i Bastioni di San Remy, guardavo verso la parete a sinistra del grande camino dove luccicavano padelle e tegami di rame di ogni dimensione. Era una parete magica!
Bastava che un piccolo raggio di sole la sfiorasse perché si accendesse e brillasse come il cielo stellato nella notte di San Lorenzo ed il guardarla mi dava il coraggio di affrontare le due ultime tappe della visita: Don Carletto e la lavanderia per salutare Gesuina, paesana di mia madre.
Arrivavo nello studio del Marchese ad occhi chiusi e quando la mamma mi spingeva con una leggera pressione della mano sulla schiena verso di lui, aprivo gli occhi ed andavo alla poltrona dove da tempo era relegato il vecchio nobiluomo.
Di lui ricordo la camicia bianca senza colletto ed il viso lungo e triste. I baffi bianchi e ben curati erano gialli nel mezzo per il gran fumare e gli occhi, ancora lucidi e neri nonostante l’età, mi guardavano con melanconica tenerezza, forse ricordando i tempi in cui quella enorme casa era affollata di bambini, i suoi figlioli.
In quella penombra vedevo il suo volto, la camicia bianca e, quando l’alzava per accarezzarmi le trecce, la mano sottile aveva un tremito. A pensarci adesso provo pena per quel vecchio che stava nel buio senza sole dei ricordi, anziché godersi il suo giardino profumato stracolmo di fiori, seduto all’ombra di una mimosa, grande e gialla come un ombrellone del Poetto.
Ai miei occhi di bambina fantasiosa Don Carletto appariva come un orco crudele, nascosto nel buio e solo grazie a mia madre che vigilava, non poteva afferrarmi per le trecce e portarmi chissà dove per mangiarmi con tutta comodità. La vista del vecchio nobiluomo, per quanto triste, non era così angosciante come il locale che ospitava la lavanderia!
Si trattava di un ambiente molto ampio situato nel seminterrato, ad altezza della strada, con la parte interna che si affacciava sul giardino. Dalle grate di ferro battuto che guardavano la grande corte orlata di ortensie e petunie, arrivava qualche timido bagliore che non bastava di certo ad illuminare altro che il davanzale degli infernotti.
Qualche lampadina dalla luce fioca pendeva sulle vasche di granito e su grossi pezzi di sapone e io mi chiedevo come poteva stare lì, Gesuina la lavandaia, tutta sola in quel posto per me terrificante. Non me ne facevo una ragione.
Era una ragazza di cui ricordo solo il nero del grembiule, grandi occhi nocciola e l’abbraccio che sapeva di sapone di Marsiglia, dal momento che passava parecchio tempo ad insaponare e strofinare panni. La visita non durava tanto ma per me era sempre troppo lunga.
Prima di lasciarci la zia ci dava ogni volta un pacchetto di dolci e quando finalmente guadagnavamo di nuovo la strada in mezzo alle case colorate, alle piazze piene di vita e di grida di bambini, il mio cuore cantava felice e saltavo sull’acciottolato come un puledro.
Il piccolo gesto insignificante, come il guardare le illustrazioni di un libro di favole dimenticato dai nipotini sul tavolo di cucina, può riportare in vita memorie incatenate le une alle altre in una sequenza di avvenimenti che si snodano come fotogrammi di un film davanti ai tuoi occhi.
A volte sono episodi particolari o semplicemente squarci di vita famigliare, cose belle e cose brutte, persone il cui ricordo fa palpitare il cuore d’amore oppure che ancora spaventano e fanno orrore.
“Dio mio” mi chiedo “perché mai ho aperto quel libro di favole, perché ho guardato quello stupido disegno, perché mi è tornato tutto in mente, tutto come un vecchio film…Il film della vita.?”
E se non vuoi più rivivere certi momenti? Sto ancora cercando di digerire i duri bocconi dei rimpianti e ancora mastico i sensi di colpa che spesso mi fanno la bocca amara come il fiele.
Gli anziani ricordano meglio le cose che furono ed io purtroppo le ricordo benissimo! Vale la pena opporsi ai ricordi? Quando arrivano… arrivano, belli e brutti tutti insieme e non c’è niente da fare, è tutta roba tua. Con quelli belli sorridi e con quelli brutti piangi ancora come allora. Quindi che faccio? Mi faccio travolgere mi dico che poi passerà e col pensiero torno indietro. Una vita fa…
Quanti anni avevo? Ero bimbetta… 4 o 5 anni, allegra e socievole, paffutella con due belle trecce nere ed una frangetta impertinente che mi scendeva sugli occhi neri, vivaci come il sorriso.
All’epoca abitavamo in un alloggio di ringhiera nel centro storico di Cagliari, al terzo piano di una casa a pianta circolare in cui tutti gli appartamenti si affacciavano sul giardino interno, molto curato, dove i bambini, una marea di bambini frutto del recente dopoguerra, non potevano assolutamente giocare. Il giardino era il fiore all’occhiello del caseggiato di Via Logudoro 15 e tutti ci attenevamo scrupolosamente a questa regola non scritta.
D’inverno i maschietti giocavano su è giù per le scale e per i lunghissimi ballatoi, rincorrendosi e schiamazzando come un’orda di barbari, mentre noi bambine, di norma più tranquille, eravamo indaffarate con bambole, piattini, tazzine da caffè e tegami, imitando i gesti e persino gli atteggiamenti delle nostre madri.
Ah…ma quando arrivavano la primavera e la lunga estate, che meraviglia, significava stare al mare da maggio ad ottobre nello stabilimento balneare dell’Aviazione, sulla spiaggia del Poetto lunghissima e larga, con sabbia bianca di borotalco, morbida come bioccoli di lana ed abbagliante sotto il sole caldissimo.
Ricordo che passavo parecchio tempo in mare. L’acqua era limpida e tiepida e minuscoli pescetti d’argento mi guizzavano fra le gambe mentre cercavo delle conchiglie “speciali” da dare a papà quando ci raggiungeva in spiaggia al pomeriggio, dopo il lavoro.
Papà era sempre allegro e quando sorrideva metteva in mostra un incisivo spezzato in modo irregolare. Questo gli dava un’aria fanciullesca, da ragazzino che ha fatto a botte e le ha prese. Gli donava parecchio. Aveva gli occhi azzurri ed i baffi e, come diceva mia madre, era bello come Robert Taylor, divo americano all’epoca famosissimo.
Papà era il mio idolo, lo adoravo. Al pomeriggio lo aspettavo impaziente di vederlo varcare la porta dello stabilimento e lo incitavo a togliersi in fretta la divisa ed indossare il costume da bagno.
Mi prendeva per mano e correvamo in mare, dove stretta al suo petto andavamo verso l’acqua alta e lì mi faceva fare “il morto”. Mi abbandona-vo fiduciosa fra le sue braccia e sentivo nel profondo del cuore che nessuno mai al mondo mi avrebbe fatta sentire così sicura e protetta. Era mio padre!
Galleggiavo a pancia in su mentre le sue mani mi sorreggevano la schiena così delicatamente da non avvertirle quasi. Sentivo le grida dei gabbiani, guardavo il cielo senza nubi sopra di noi, i suoi occhi azzurri ed i suoi baffi, che di tanto in tanto mi solleticavano il naso, la fronte e le guance, con piccoli baci.
La lunga estate passava al mare, con mio padre e mia madre. Estate tranquilla fatta di piccole cose: lunghi bagni, la raccolta delle conchiglie, castelli di sabbia e risate. Nonostante le macerie della guerra fossero ovunque a ricordare l’orrore appena finito, non ne avevo la consapevo-lezza e niente mi turbava o feriva la mia voglia di giocare, saltare come un grillo ed andare sul Bastione di San Remy a mangiare il gelato o a girare sulle giostre
Spesso, prima di andare a dormire, obbligavo papà, pazientissimo, al gioco del parrucchiere e lui si divertiva con me. Con il pettine delle bambole e lo spazzolino delle unghie, gli spazzolavo i baffi in su ed in giù, gli mettevo il profumo, li spazzolavo nuovamente, glieli tiravo fino a che mia madre, mai lui, spazientita, non mi portava a letto dopo il suo ultimo bacio.
Ero innamorata di papà. Amavo i suoi baffi, gli occhi azzurri e l’incisivo spezzato che si notava quando sorrideva. Mi fidavo di lui e crescendo avrei creduto che tutti gli uomini sarebbero stati buoni, gentili, con le braccia forti e delicate dove trovare un posto sicuro… per piangere, se fossi stata triste o per ridere condividendo la stessa allegria. Esattamente come facevo con lui!
Altri ricordi arrivano piano, fantasmi del passato e poi continuano…mio Dio se continuano…implacabili. Sapevo che mi avrebbero fatto male…ma ormai era troppo tardi per pensare ad altro…troppo tardi.
Ricordo … ero seduta in un bar del Poetto con il mento appoggiato al palmo della mano e gli occhi che vagavano ora sulla sabbia bianca e luminosa, ora sul mare azzurro e pensavo a quanto era stato bello e perfetto il mondo della mia infanzia.
Pensare a papà dopo tutto quello che mi era successo, mi dava una dolcezza ed uno struggimento da sciogliere il cuore, una sensazione di stordimento fisico. ”Papà” dissi in un sospiro “come avrei voluto le tue mani forti e leggere a sostenermi la schiena e non le sue a massacrarmela!”.
Da sotto gli occhiali da sole mi scivolarono due lacrime che andarono a perdersi nelle cicatrici che allora non erano del tutto guarite. Una sullo zigomo destro e sopra il labbro superiore mentre sulla parte sinistra, uno sfregio roseo e lucido univa l’occhio al labbro inferiore. I medici mi garantirono che le ferite sarebbero scomparse con qualche altro intervento di chirurgia plastica…e così avvenne nel corso degli anni.
Ancora oggi, quando sono particolarmente agitata, mi strofino dove adesso c’è solo più il ricordo dell’antico sfregio e sento un tremito freddo che mi afferra lo stomaco, nonostante gli anni trascorsi siano ormai tanti.
Altre ferite ed ammaccature erano nascoste sotto un completo di lino bianco…ricordo che lo indossavo quel giorno al Poetto. Amavo tanto il bianco ed ancora lo amo, anche adesso che sono vecchia. Il bianco sa di purezza, innocenza, sa di lenzuola pulite e profumate di lavanda, proprio come quelle del mio letto di quando ero una bambina felice.
Le ferite dell’anima no, quelle non si vedono ma sono molto peggio degli sfregi, delle ossa rotte, degli occhi tumefatti e sono proprio loro che tolgono la stima in te stessa, la fiducia negli altri, la speranza di un amore sano e bello e di un futuro senza paura e senza incubi.
Io avevo fiducia nelle persone, perché mai non avrei dovuto averne? Papà e mamma amorevoli, parenti ed amici fidati e di cuore, baci e carezze erano il mio pane quotidiano anche se non mancavano i rimproveri ed i castighi che, quando mi erano dati, erano sempre motivati e mai oltre la mia capacità di capirne il senso e la portata.
Com’è vivido il ricordo di quel giorno al Poetto! Tutto è presente come fosse ieri, anche i particolari più insignificanti. Mi ero tolta gli occhiali da sole e li avevo appoggiati sul tavolino dalla tovaglietta azzurra con disegnate delle conchiglie bianche, accanto al portacenere di vetro con la scritta Carpano.
Mi strofinai gli occhi umidi, quasi a cancellare una brutta visione. “Stupida, stupida, stupida” mormorai in un soffio ripensando con un brivido a come l’amore che avevo vissuto era diventato l’orrore che per poco non mi uccideva.
Mi chiesi come avevo potuto amare un essere senza cuore né morale fino al punto di sposarlo e continuare a non capire. Perché gli avevo permesso di entrare nel mio mondo e di fare a brandelli la mia dignità ed il mio corpo?
Avevo creduto che lui fosse l’amore della vita. Gli avevo dato i miei sogni e le speranze, la tenerezza e la mia comprensione, ero totalmente fiduciosa, gli avevo messo fra le mani anche la mia anima.
Ormai i ricordi non li fermava più nessuno, nemmeno la mia volontà di ignorarli o di tenerli a freno. Arrivavano impetuosi come raffiche di vento e non mi restava che piegarmi alla loro forza come facevano le palme lungo il mare del Poetto “Prima o poi cesseranno di tormentarmi” mi dicevo …
Mi rivedo a quel tavolino mentre le mie dita tremanti indugiavano sulle cicatrici del viso. Sul taglio che raggrinzava il labbro verso le narici e scopriva il vuoto di un dente, e mi chiedevo se e come avrei fatto a dimenticare, quando l’incubo di ciò che avevo vissuto mi guardava dallo specchio, dal riflesso in una vetrina, dagli occhi di chi incrociavo per la via o dallo sguardo dolente di chi mi amava.
Mi rimisi gli occhiali, ordinai un caffè e poi fumai una sigaretta. Sentivo che i nervi pian piano si rilassavano, guardai il mare ed affondai i piedi scalzi nella sabbia calda. Ero contenta di essere tornata dove ero stata felice e voltando il capo verso lo stabilimento dell’Aviazione vidi papà che correva in acqua tenendomi stretta al petto … mi portava dove non si tocca a fare il morto.
Mi vedevo galleggiare a pancia in su con le sue mani forti che mi reggevano la schiena, quelle si erano dolci ed amorevoli! Esattamente così avrei voluto che fossero le mani a cui intrecciare le mie per sempre.
Dopo tutto la vita mi ha voluto bene ed il tempo è stato un farmaco potente. Sono guarita nel corpo ed ho imparato a convivere con le cose brutte mai dimenticate. Adesso sono una donna anziana e la mia anima ancora arranca un po’ lungo le strade della vita, ma ogni volta che vado a Cagliari torno alla spiaggia ed allo stabilimento al mare perché ho un appuntamento a cui non voglio mancare: c’è papà che mi aspetta.

Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione –
Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale.